
❧ Quella meravigliosa polvere
E se la mia faccia è la maschera che ogni giorno indosso,
giorno dopo giorno scelgo di giocare.
Ma questo è un gioco che conduco io.
Guardavo le commedie di Edoardo alla TV.
Ero piccola. Vivevo in un paesino di montagna.
Lontano dal mondo.
Avvolta da malinconie senza perché e da tristezze che avevano tanti nomi.
Una tristezza si chiamava solitudine.
Un’altra si chiamava voglia di abbracci.
Un’altra si chiamava voglia di giocare.
Non avevo nessuno che mi ascoltasse.
Non avevo braccia in cui rifugiarmi.
Non avevo amici con cui giocare.
Guardavo la TV.
Sognavo i sogni degli altri. Fantasticavo. Mi raccontavo storie che un giorno avrei vissuto. Ne ero certa. Le commedie e gli sceneggiati della TV di allora mi regalavano un grande occhio con cui guardare altrove. Era il mio mondo vero, quello che osservavo in bianco e nero, ed era molto più interessante e luminoso della realtà immersa in un grigiore di abitudine e grettezza.
Leggevo molto. Narrativa per ragazzi. Fumetti. Riviste passate dalla parrocchia. E quando altro non c’era, etichette delle bottiglie, reclame, manifesti mortuari… Dovevo leggere. Qualunque cosa.
L’importante era soddisfare la sete di curiosità.
Per qualche ragione a me oscura, tutto ciò che non riguardava la scuola mi veniva proibito o non incoraggiato. Io volevo cantare… e mi graffiavo la gola con i canti della messa. Volevo ballare… e mi inventavo percorsi in equilibrio su muretti e sulla vasca da bagno. Volevo recitare… e mi creavo interminabili monologhi da declamare quando potevo girare per casa indossando lunghe camicie da notte rubate alla mamma. Non mi guardavo allo specchio mentre giocavo al teatro. La mia immagine di bambina goffa e grassa avrebbe interrotto l’incantesimo che mi disegnava esattamente come la fantasia del momento mi pretendeva. Era il mio piccolo segreto inconfessato, inconfessabile. Solo mamma poteva sbirciare le mie esibizioni che non si interrompevano sotto il suo sguardo sorpreso e sorridente che mai, mai mi derideva.
Il mio mondo era lì, custodito dentro lo scrigno ermetico della mia fantasia. La vita scorreva senza penetrare nell’anima che doveva sopportare giornaliere ferite lenite subito dalla meravigliosa solitudine che mi consentiva di entrare nel mio fantastico mondo segreto.
Era talmente popolato di personaggi e di storie, il mio mondo, che non potevo dare spazio ad altro.
La scuola era noiosissima, tranne lo svolgimento di qualche tema in cui potevo esprimere un pezzetto del mio universo.
Si passavano i miei temi, i maestri. Si chiedevano sconcertati come fosse possibile scrivere in modo eccellente in italiano ed essere completamente asina in tutte le altre materie.
Credo pensassero di avere scoperto una singolare forma di demenza. Io, scema speciale.
Non ero molto preoccupata di farmi valere. Volevo solo che mi lasciassero in pace, che non mi disturbassero mentre mi raccontavo le mie storie. Storie che non avrebbero mai ascoltato, non avrebbero mai capito. Ricordo l’acuto desiderio di possedere costumi d’epoca, cappelli, accessori… tutto ciò che avrebbe potuto vestire i miei personaggi che bussavano ansiosi e nudi in attesa di potersi svelare e raccontarsi. Mi sentivo posseduta da loro. E avevo la necessità di indossare cose strane durante i miei giochi. Mi sembrava, così, di farli respirare un po’, di concedere loro un pizzico di vita vissuta. E desideravo un corpo adatto a portare abiti giusti per i miei amici destinati a rimanere fantasmi, se non davo loro la possibilità di manifestarsi attraverso le mie azioni, la mia voce.
La vera solitudine, l’unica insopportabile è sapere che nessuno ti vuole ascoltare. Avevo un mondo immenso da raccontare ma nessuno era interessato a conoscerlo. Ero avvilita per i continui rimproveri dovuti allo scarso rendimento scolastico e alla poca propensione a diventare assennata. Ero un fallimento. Una bambina ingombrante, irritante, inetta.
Accettavo con rassegnazione il mio ruolo. Sembrava che nulla potesse far cambiare opinione su di me. Vanificato ogni mio sforzo di piacere e compiacere.
E continuavo a fantasticare. I miei libri mi consolavano. Lì, c’erano storie simili a quelle che inventavo. E le bevevo avidamente, con un vago senso di trasgressione, di colpa: preferivo leggere invece che memorizzare le tabelline o le date di storia.
E poi osservavo il mondo che mi circondava. Un mondo piccolo piccolo fatto di eventi insignificanti a cui veniva data un’importanza che non comprendevo. Osservavo e mi sembrava di assistere a una commedia dai tempi sbagliati. Erano copioni poco interessanti. Erano attori poco versatili.
Era perfetto il contesto. Era affascinante il linguaggio. Ma la messa in scena necessitava di aggiustamenti. Non c’era svolta, in quelle storie. Non c’era controparte. Non c’era suspense.
Tutti i personaggi condannavano o approvavano. Coro noioso di voci che pontifica. Censura. Mormora senza dire. Guarda senza vedere. Nessuna possibilità di catarsi. Nessuna domanda viva. Nessuna risposta convincente. Un mesto girotondo nella penombra. Uno stucchevole ritornello cantato a mezza voce. Una stasi vischiosa e rassicurante. E la mia mente attingeva per volare presto lontano. Rivisitavo le storie che pulsavano attorno a me. Le sbucciavo con impietosa determinazione, buttando via le scorie e salvandone l’essenza che vi scorgevo. Un’essenza inesprimibile eppur degna di essere raccontata. Le ho archiviate per anni, quelle storie. Credevo di averle dimenticate, ma sono riemerse e sono diventate commedie. Non sempre rappresentate con i colori celati dentro pause e parole… ma respirano tutt’oggi la meravigliosa polvere di palcoscenico.
❧ Quell’odore speciale
Lievi
i venti dell’Arte
alitano
silenziosi
costanti.
Grovigli di tormento
sofferenze e pensieri.
Lievi
di nostalgiche illusioni
affilando il coraggio
si negano.
E nella solitudine
esplodono.
Il teatro ha un odore speciale.
Sa di cose cercate con ansia, ritrovate con stupore, donate per necessità.
Ma quando iniziai a recitare sentivo solo la gioia del gioco creativo.
Non sapevo altro.
Mi bastava assaporare la danza del cuore che cantava, finalmente, libero di esistere.
Tutto ebbe inizio con l’allestimento di una recita scolastica.
Avevo dodici o tredici anni, non ricordo. So con assoluta certezza che non avevo mai smesso di raccontarmi le storie che inventavo.
Io non partecipavo alla rappresentazione. Ero sempre presente alle prove, però. Presente con lo sguardo avido e le percezioni vive.
Osservavo ciò che accadeva, invidiando il coraggio di chi osava esibirsi e la determinazione di chi dirigeva il lavoro. Non ricordo cosa si metteva in scena. Ricordo che la sera prima della presentazione al pubblico, l’insegnante che coordinava il gruppo di studenti disse qualcosa a proposito della necessità di spazzare il palco.
Io mi alzai dalla sedia della prima fila e cominciai a raccogliere cartacce e affini con le mani nude.
L’insegnante urlò qualcosa. Io rimasi congelata dalla vergogna: non mi sarebbe stato concesso neanche di pulire…? Poi mi venne detto che avrei potuto usare le scope che avrei trovato dietro le quinte. Questo significava che sarei salita sul palco. Trovai le scope e iniziai a spazzare. Felice! Ero felice! Attraversavo il palco in lungo e in largo. Spazzavo con cura le tavole vecchie e scricchiolanti. Respiravo l’odore di polvere annidata nei pori del legno. Nessuno mi disturbava. Potevo navigare tra i miei pensieri e fantasticare. Ero su un palco. Guardavo le file ordinate delle sedie di legno giù in platea e immaginavo il pubblico che rideva, applaudiva, si emozionava.
Ero protagonista fantastica in un luogo fisico, reale. Mi guadagnavo il privilegio di calpestare le sacre tavole pulendole con cura meticolosa. Non ricordo altro di quell’esperienza. Mi è rimasta addosso l’euforia della partecipazione a un evento.
Qualche anno dopo, avevo sedici anni, cominciai a frequentare un gruppo che frequentava l’Oratorio Don Bosco: i Cooperatori Salesiani.
Ragazzi e ragazze che cantavano in chiesa, organizzavano piccoli eventi a scopo benefico e allestivano spettacoli canori e teatrali. Mi fu consegnato un copione e mi fu chiesto di suggerire durante le prove. Il sottopalco era umido, puzzolente e freddo. La botola del suggeritore era una specie di piccolo pozzo che sbucava nel sottopalco. Su una specie di pedana c’era la sedia che ti permetteva di sbucare con la testa all’altezza del palco; il resto del corpo era ingoiato dal vano umido che in inverno si trasformava in acquitrino. Se si sentivano rumori strani provenienti da sotto, bisognava ignorarli: nessuno avrebbe avuto il coraggio di espletare il ruolo di suggeritore se pensava ai topi vari ed eventuali che passeggiavano giù nel buio.
Il copione tra le mani, mi sentivo privilegiata, potente. Conoscevo tutte le battute a memoria. Provavo una sincera ammirazione per Francesco, il capocomico che curava anche la regia. Aveva recitato innumerevoli volte, lui. Conosceva i segreti del teatro. E tutti lo ascoltavano e lo rispettavano. Man mano che il testo prendeva forma sulla scena, mi sembrava di familiarizzare con i personaggi e gli eventi. Senza rendermene conto, cominciai a suggerire anche movenze e gesti, oltre alle battute. Ingessato dentro la botola angusta e puzzolente, il mio corpo danzava insieme ai ritmi del testo e gioiva di gioia inedita e di scoperta affascinante. Una sera, Francesco urlò qualcosa contro di me. Non recepii subito il significato delle parole. Ero troppo imbarazzata per il tono della voce inequivocabilmente destinato a qualcosa di sbagliato che avevo fatto. Poi, compresi. Diceva, irritato, che il suggeritore non doveva far altro che soffiare discretamente le battute, non doveva in alcun modo interpretare! Ero troppo espressiva. Avrei fatto meglio a recitare. E mi costrinse a salire sul palco per sostituire una ragazza assente alla prova. Ubbidii più per timore che per convinzione. Conoscevo ogni singola battuta, la sostituzione funzionò. Sostituii la ragazza e recitai.
La sera della prima, l’euforia mi annebbiava la mente. Sbirciai giù in platea e vidi che le sedie si riempivano alla spicciolata. Quando il sipario si aprì, uno strano formicolio invase il mio corpo.
Entrai per la mia prima battuta. Un istante di panico. Un solo istante in cui mi passarono per la mente tutti i pensieri del mondo. Provai l’impulso di scappare, di non tornare più in quel luogo stregato. Centinaia di visi protesi verso di me. Centinaia di sguardi appiccicati addosso. Scappo e mi salvo? Resto e mi abbandono al gioco? Rimasi. E la voce uscì, ogni oltre mia previsione, al di là della mia volontà, posseduta da una forza vitale che non sapevo di avere. Recitai. Recitai bene.
E iniziò l’avventura che non ho più abbandonato.
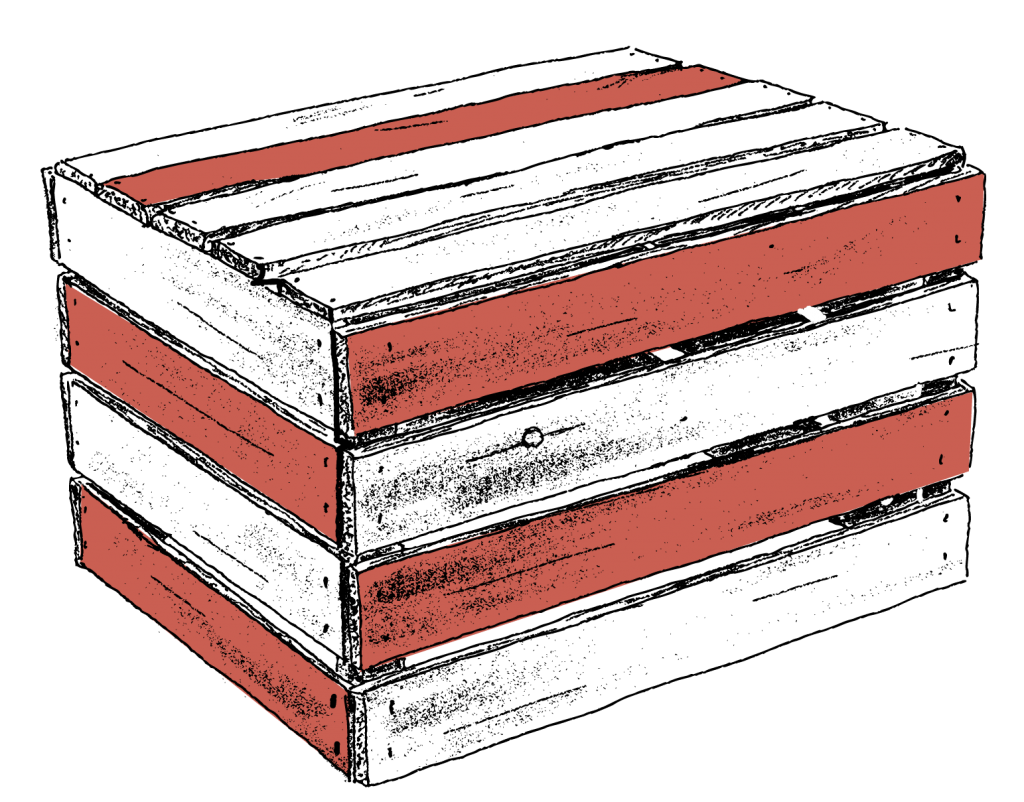
❧ Necessità
C’è un foglio bianco dentro la mia anima
e ognuno
ci scrive sopra parole
che non mi appartengono
ma hanno la mia voce.
Ho iniziato a scrivere di teatro per necessità. Bisognava andare in scena e il mio gruppo teatrale era a corto di copioni. Si mettevano in scena quasi esclusivamente commedie brillanti in vernacolo. In seguito le mie commedie furono molto apprezzate dai numerosi gruppi teatrali che tuttora le mettono in scena e molto snobbate da chi ritiene che la commedia in dialetto sia futile rappresentazione. Non entro in merito alla qualità intrinseca dei miei lavori perché non tocca a me giudicarli. Mi limito a osservare che, al di là del genere scelto, il teatro deve essere proposto con la consapevolezza del cosa fare e come farlo. Mi è molto piaciuto scrivere le commedie e mi è molto piaciuto rappresentarle.
Probabilmente, il gusto della scrittura seguita dalla messa in scena mi ha dato la possibilità di ironizzare su eventi e situazioni che respiravo nel quotidiano e condizionavano la mia libertà di espressione poiché nei microcosmi dei piccoli centri è necessario lasciarsi guidare dalle convenzioni se non si ha il coraggio o la capacità di smantellare modi di pensare radicati e perpetuati grazie all’unanime consenso.
La gente rideva alle mie rappresentazioni. Si divertiva. Molto. In cosa consisteva il vero spasso? Nelle situazioni comiche ben costruite? Nei dialoghi divertenti? O nel riconoscimento dell’autocritica? Non mi è dato di sapere. Probabilmente nessuna persona che ha ispirato le vicende raccontate si è riconosciuta nel personaggio che la rappresentava.
Credo di avere raccontato nelle mie commedie buona parte di ciò che ho osservato durante l’infanzia e l’adolescenza. Tengo a precisare che molti spunti di ispirazione sono emersi dalla feroce autocritica dedicata a me stessa: sono stata figlia anche io dei costumi che descrivo con sarcasmo. Forse mi autoassolvo perché nell’autocritica ho trovato le risorse necessarie al cambiamento.
Non ero consapevole, mentre scrivevo le commedie, di contribuire alla preservazione di un patrimonio lessicale che è andato via via perduto o irrimediabilmente trasformato dalla contaminazione di una modernità che ha omologato e svuotato della sua poetica i piccoli centri. Si è confusa la civiltà con il modernismo. La globalizzazione con l’annullamento identitario. Ma ci sono personaggi ben più qualificati di me che potrebbero approfondire la questione.
Al di là della lingua, le commedie hanno, ancora oggi, un contenuto riconoscibile perché la dimensione che riguarda le relazioni interpersonali ed i sentimenti non può non essere universale.
Poi, non ho sentito più la necessità di esprimermi con una lingua che, anche se mi apparteneva intimamente, non era più esaustiva rispetto alla mia voglia di esplorare altri linguaggi e di trasmettere altri contenuti. Non ho per questo rinunciato all’uso del mio dialetto poiché mi consente di esprimere sentimenti e situazioni che mi sembra possano essere esternati unicamente con quei suoni e quel lessico. Faccio ricorso al dialetto per le numerose storie in versi che ho scritto e che sono diventate canzoni o testi da musicare.
Ho smesso di scrivere commedie in dialetto nel 1996.
Mi sono dedicata, in seguito, ad altre tracce di lavoro.
Ho scritto testi teatrali per bambini, ragazzi, adulti. In italiano. In altri lavori ho utilizzato inserti dialettali perché mi permettono di parlare di sentimenti con l’intensità che solo il dialetto può restituirmi.
La pregnanza del dialetto, le sue sonorità, la sua forza espressiva sono insostituibili.
La lingua italiana mi consente di trovare un contenitore idoneo a depositare situazioni sceniche di più ampio respiro. Da anni, ormai, scrivo i testi in itinere. Una sorta di work in progress che si articola durante gli incontri di laboratorio. Mi affascina la possibilità di creare un testo insieme ai partecipanti. Né io né loro sappiamo cosa scaturirà dai nostri incontri. Il testo ci esplode in mano e prende forma man mano che le sinergie si affinano.
Raramente propongo testi già confezionati da mettere in scena. Molti dei copioni che ho scritto non sono stati mai rappresentati. Sono lavori scaturiti da un intuito, un’improvvisa necessità o semplicemente dalla voglia di raccontare.
❧ Io, teatrante
Quando
cerco di comunicare i miei pensieri
produco buffi suoni a forma di parole.
Ho iniziato l’attività teatrale come autrice nel 1981.
Il primo copione originale, ’U femminismu, fu rappresentato nello stesso anno dal gruppo di amici che ebbero la bontà di seguirmi in quell’avventura.
Compresi subito l’importanza di realizzare lavori originali e continuai a produrre commedie che man mano vennero rappresentate con discreto successo.
Rappresentare propri lavori, comporta una notevole libertà ma implica una responsabilità non facile a sostenersi.
Nonostante le difficoltà, le critiche, le crisi di varia natura il gruppo allora denominato La Clessidra continuò la propria intensa attività fino al 1987.
A causa di dissapori e contrasti al suo interno, il gruppo si ricostituì e prese un altro nome: ’A Lumera.
L’attività de ’A Lumera fu davvero breve poiché, a causa di gravi problemi economici, il gruppo dovette vendere tutte le attrezzature in suo possesso e abbandonare l’attività teatrale.
La mia produzione di commedie continuava e numerosi gruppi teatrali calabresi cominciarono a mettere in scena le mie opere.
Nel 1994 il Circolo Culturale Brancaleone mi offrì la possibilità di ricominciare l’attività teatrale mettendomi a disposizione il necessario per la rappresentazione.
Nacque così Maschere Vere che ha inaugurato il suo ingresso nel mondo teatrale con la commedia Cicciu ’u pacciu. La commedia ebbe un inaspettato successo; ancora oggi continua a essere rappresentata da numerose compagnie teatrali.
Molti gruppi teatrali scelgono di rappresentare le mie commedie.
Molte scuole rappresentano ogni anno i miei testi.
Naturalmente, mi lusinga il fatto che tante persone prediligano i miei lavori ma mi rattrista constatare che qualche volta la scelta viene operata unicamente perché si ha voglia di testi gioiosi, apparentemente semplici che vengono, a mio avviso, rappresentati con eccessiva disinvoltura.
Fortunatamente c’è anche chi sente l’esigenza di una continua crescita e dedica attenzione e meticolosa cura all’allestimento di un lavoro.
La scelta delle mie commedie in ambito scolastico mi intenerisce anche se mi induce a doverose riflessioni; questi testi non sono stati scritti per essere rappresentati dai bambini. Mi preoccupa il fatto che, pur di rendere accattivante a ogni costo uno spettacolo, si possa trascurare l’aspetto formativo e pedagogico che l’esperienza recitativa dovrebbe implicare. Sicuramente l’esibizione di bambini vivaci che scimmiottano gli adulti per atteggiamenti e movenze può suscitare il sorriso, ma ciò ha un senso se l’espressione è una spontanea scelta di riprodurre, personalizzandolo, il mondo circostante. Indurre i bambini a emulare un universo che non è il loro in quanto non appartiene al vissuto personale né per vicende, né per interiorizzazione di esperienze, può rivelarsi inutile, persino patetico.
Altro è, invece, scegliere un testo brillante in vernacolo perché potrebbe offrire un ottimo pretesto per il recupero del dialetto, delle tradizioni, dei valori dimenticati. Oppure potrebbe divenire strumento critico rispetto ad una mentalità becera e circoscritta a microcosmi che non agevolano l’autentica crescita.
È importante, a mio parere, fare scelte consapevoli rispetto al testo da rappresentare. Chi agisce esibendosi deve poter padroneggiare l’azione e non subirla obnubilato dall’ansia dell’approvazione.
Per quanto riguarda i gruppi teatrali devo con amarezza constatare che qualche volta si tende a crogiolarsi nella convinzione che tutto ciò che riguarda il teatro popolare implichi la scelta di testi poco impegnati e che questo autorizzi l’allestimento di rappresentazioni poco apprezzabili dal punto di vista artistico. Ma non è vero che il teatro popolare coincide con la spensierata e superficiale messinscena di opere “leggere”. Il teatro popolare è, dovrebbe essere, uno spazio dove creatività, tradizione, esperienza e competenza si fondono per esprimere un genere teatrale assolutamente godibile, fruibile da tutti e al tempo stesso apprezzabile anche da chi osserva con sguardo attento e, perché no, esigente.
Se il teatro popolare è stato relegato in ambiti eccessivamente ghettizzati rispetto a generi che, a torto o a ragione, vengono definiti culturalmente più stimolanti, la responsabilità è anche di chi crede che basti suscitare qualche risata in più per ottenere approvazione incondizionata. Sbagliato. La gratificazione vera proviene dalla consapevolezza di aver lavorato seriamente. Registi, attori, scenografi dovrebbero agire in sinergia chiedendosi continuamente il senso delle loro scelte, del loro operato. Non esistono generi teatrali più o meno dignitosi o interessanti; esiste un modo dignitoso e interessante di procedere con coerenza e consapevolezza lungo il percorso creativo ed artistico che s’intende intraprendere.
Ci sono decine di modi per dire un’unica battuta; la creatività suggerisce i molti modi, l’arte individua l’unico modo esatto per dirla.
È un lavoro lungo e faticoso, spesso frustrante ma estremamente gratificante perché dà un senso al proprio agire.
Il dialetto è patrimonio prezioso e insostituibile. Così come il linguaggio di una commedia ambientata in un preciso momento cronologico deve essere supportato da una terminologia adeguata all’epoca (alcuni vocaboli sono recuperabili solo attraverso la tradizione orale), allo stesso modo anche oggetti di scena e costumi devono essere congruenti con gli usi ed i costumi del tempo a cui il lavoro si riferisce.
Una meticolosa ricerca che prevede il recupero degli oggetti di scena e la fedele riproduzione dei costumi, insieme ad una regia oculata regalano autentici spaccati di vita passata.
Allora sì, che la commedia ha una sua funzione; il percorso nostalgico della memoria viaggia insieme al lieto recupero di ciò che non è più ma, trasformandosi, può essere riconvertito in giocosa ma utile osservazione critica rispetto ai valori, agli atteggiamenti, alla mentalità di nuclei sociali che, pur proiettandosi nel futuro, non intendono rinunciare al proprio patrimonio culturale.
La risata, sì! Ma che sia straripante di allegria ed intelligente sarcasmo. La volgarità gratuita e le parolacce fanno forse sghignazzare ma non lasciano che tracce di vuoto.
Buon lavoro, quindi a chi si dedica al teatro con passione e consapevolezza.
Grazie alle compagnie che scelgono di rappresentare i miei lavori.
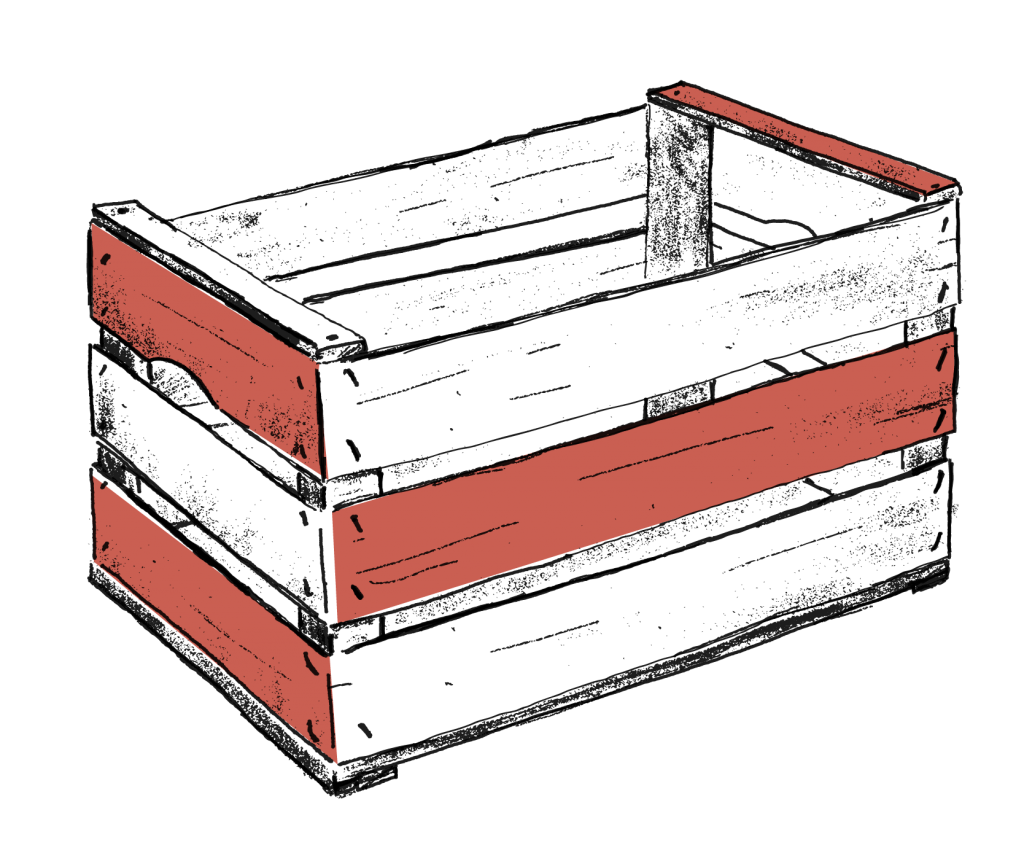
❧ Il gioco del teatro
Ti insegnerò
a giocare con il corpo e le parole.
Imparerò da te
che il corpo non è casa e non ha strade…
È libero torrente, il corpo…
Si contorce quando incontra la roccia.
A volte singhiozza, impotente, stremato di pioggia negata.
Ma troverà, infine, il suo mare.
L’esigenza di armonizzare la lunga esperienza vissuta nell’ambito del teatro popolare con i più recenti lavori messi in scena, mi spinge a ipotizzare un genere teatrale nuovo rispetto agli usuali schemi scelti dalla maggior parte delle compagnie di teatro popolare e che io stessa ho per molti anni adottato.
Mi piace pensare a una messa in scena che utilizza ritmi, sonorità, situazioni peculiari della commedia di ispirazione popolare e tuttavia respira in un contesto scenografico più snello e fresco.
L’dea è di spogliare la scena, renderla essenziale sia come effetto cromatico che come oggetti scenografici.
L’ambientazione è determinata dall’estrema cura nella scelta dei costumi, trucchi, accessori e degli oggetti di scena che vengono utilizzati dai personaggi: nessun oggetto che non sia funzionale alla scena deve apparire.
Scatola scenica uniforme e neutra.
Luci piazzate in modo da esaltare l’azione.
È un esperimento che può essere tentato anche con le commedie popolari di struttura tradizionale ma bisogna tener conto del fatto che gli elementi scenografici condizionano le azioni sceniche, per cui quest’operazione è possibile laddove si è in grado di apportare gli aggiustamenti registici necessari.
Un primo esperimento è stato già proposto durante la presentazione della collana “Gli inediti” pubblicata a cura del Teatro Gruppo Spontaneo di Bovalino.
La presentazione prevedeva l’allestimento di scene scelte ed estrapolate da più copioni.
In quell’occasione la scatola scenica era nera; i cambi scena avvenivano “a vista” ed effettuati da ragazze che svolgevano il loro compito avvalendosi di movimenti sincronizzati, precisi, studiati. Quasi una coreografia dalla struttura semplice, essenziale ma rigorosa.
Questo metodo di lavoro da me proposto offrirebbe, a mio avviso, l’opportunità di trasformare il teatro popolare in uno spazio sperimentale dove tradizione e modernità possono intersecarsi superando il rischio della ripetitività a volte stucchevole e della noiosa prevedibilità.
La struttura drammaturgia della commedia, nelle mie nuove proposte di testo, è riconcepita, smembrata, “giocata” con sfrontata libertà.
È un modo per spaziare tra i paradossi della quotidianità svincolati dalla necessità di “riprodurre” il vero. È un modo accattivante e incisivo di sottolineare, esaltandola, la follia del vivere nella sua più autentica e inquietante forma.
Il testo, se è valido, parla da sé. Non occorre modificarlo nella struttura e tantomeno nel numero dei personaggi. Il testo va “ascoltato”. Se non convince per qualsiasi ragione, basta accantonarlo. Ogni autore vuole dire qualcosa di preciso attraverso il suo scritto; ogni “aggiustamento” deve essere vissuto con la consapevolezza che, probabilmente, la sua intenzione verrà deviata o, peggio, svilita.
È necessario, inevitabile apportare ragionevoli modifiche rispetto al lessico o alle frasi idiomatiche che non trovano riscontro fedele nella trasposizione linguistica da un dialetto all’altro, ma anche questa operazione va compiuta con estrema attenzione.
Spesso si aggiungono frasi o battute ideate per “strappare la risata” a ogni costo. Operazione che si intravede anche nella caratterizzazione di alcuni personaggi. Questa modalità di intervento è deleteria ai fini di un risultato credibile e rappresenta un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti dell’autore.
Già di per sé la personalizzazione registica implica una sorta di rivisitazione. È inevitabile che chi dirige lasci la propria traccia e il proprio stile. Ma questo nulla ha a che vedere con i rimaneggiamenti che fanno di una commedia “un’altra cosa”.
Chi ha velleità simili, che si cimenti nella scrittura.
Che produca propri testi.
Che si assuma la responsabilità di una creazione totale.
Troppo semplice e semplicistico rimaneggiare il lavoro altrui deformandolo nella forma e nell’essenza.
A chi afferma che “il lavoro funziona”, rispondo che le risate e i complimenti non sempre sono reale riscontro di un valore artistico intrinseco.
Bisogna avere la pazienza, l’umiltà ed il coraggio di proporre lavori “puliti” e “intellettualmente onesti” nella loro confezione ultima e nel percorso di montaggio.
Troppe volte ho assistito a rappresentazioni che sarebbero state godibili senza gli orpelli inutilmente aggiunti di caratterizzazioni volgari o pacchiane; di scene superflue; di volgarità gratuite.
Mi è impossibile contattare tutti i gruppi teatrali che hanno scelto di rappresentare le mie commedie ed i gruppi che conosco viaggiano seguendo le loro convinzioni sul modo si allestire i miei lavori.
Mi piacerebbe, però, poter dire a coloro che delle mie commedie hanno fatto il loro itinerario artistico, che non condivido l’inserimento di elementi che distorcono in parte o completamente il significato che ho cercato di esprimere scrivendo e immaginando la messa in scena dei miei lavori.
Nessuna polemica. Solo desiderio di sottolineare il valore che ho dato al lavoro di scrittura che ho affidato ad altri nella speranza che queste creature da me partorite possano vivere e crescere senza perdere l’essenza che le ha fatte nascere.
Maria Pia Battaglia